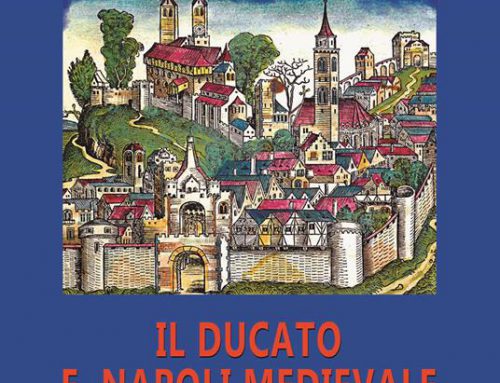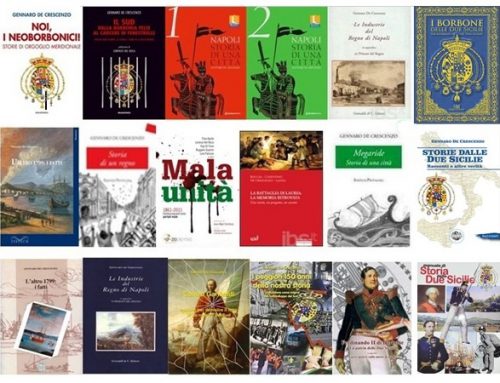In premessa un ringraziamento al Mattino (15/9/21) per il sorriso che ci ha strappato: nella (ovvia) recensione carica di entusiasmo contro i Borbone e per un libro che dovrebbe servire a smantellare le fake news “neoborboniche”, svetta una grande foto con una bella didascalia: “Le violenze. In un dipinto, i sanfedisti alla riconquista della città nell’estate del 1799”. Peccato che si tratti del famosissimo quadro di Micco Spadaro dedicato alla rivoluzione di Masaniello nel 1647…
Raramente, in questi anni, abbiamo letto un libro tanto parziale e in grado di suscitare in noi sensazioni sgradevolissime per l’argomento trattato e per come è trattato. Stiamo parlando di “I cannibali dei Borbone” di Luca Addante per la casa editrice Laterza (della quale, negli ultimi anni, notiamo un significativo e in fondo divertente accanimento nella pubblicazione di libri contro Borbone&borbonici). Fin dall’introduzione si leggono affermazioni surreali anche se con la (ormai) consueta attestazione del grande successo neoborbonico. E da quel successo forse si parte anche per motivi commerciali seguendo uno schema ripetitivo con titoli che riportano parole-chiave come “Borbone, borbonici, Due Sicilie, neoborbonici” ecc. ecc. Per l’autore, allora, quella neoborbonica, da più di vent’anni, da minoritaria è diventata “una potente macchina comunicativa” e (non si sa perché, visto il tema e il tono di un libro che dovrebbe essere accademico) si cita il testo di una bella canzone di Povia (“A Sud”). Così la strofa “il Sud era ricco e con l’unità d’Italia diventò povero” per l’autore è una “baggianata”. Peccato solo che (senza cantare) colleghi dell’autore e docenti titolari di cattedra come Daniele, Malanima, Fenoaltea, Ciccarelli, Tanzi, Collet, De Matteo, Davis e lo stesso Nitti abbiano attestato e documentato la crisi del Sud (solo) dopo il 1860.
Così la frase “al Sud nessuno emigrava” pure sarebbe una “baggianata” perché non prende in considerazione, per l’autore, “le migliaia di esuli politici o i migranti stagionali che per secoli e secoli si spostavano da una regione all’altra”. Qui l’autore ci sorprende davvero perché arriva a mettere sullo stesso piano gli emigranti stagionali e regionali e la grande emigrazione meridionale (circa 5 milioni di persone dal 1870 alla prima metà del Novecento, oltre 20 milioni fino ad oggi) e scrive di “migliaia di esuli” quando un’altra sua collega titolare di cattedra (Renata De Lorenzo) attesta l’esistenza a Torino di meno di 100 esuli. Nella stessa premessa, infine, mette sullo stesso piano pure briganti e mafiosi arrivando addirittura a preoccuparsi del fatto che in futuro qualcuno possa celebrare i secondi dopo aver celebrato i primi, criminalizzati, nel testo, fino ad associarli al cannibalismo. Qui, in fondo, il cuore del libro stesso che, secondo la felice definizione inventata dal prof. Luigi De Matteo, risente in pieno del “tesismo” spesso rilevato nelle accademie. In pratica ci si innamora di una tesi e la si porta avanti tenendo conto solo delle fonti che la confermano o leggendo le fonti in un’unica direzione. Premesso che lo stesso Carmine Pinto nel suo testo sul brigantaggio citato anche dall’autore non evidenzia affatto questo ipotetico filo rosso tra briganti e camorristi/mafiosi, un vero “esperto del settore” come il giudice Gratteri non usò parole dolcissime contro quelli che “non sono in grado di distinguere le origini della picciotteria e quelle del brigantaggio”. Su questo, allora, mi sento di tranquillizzare l’autore perché nessuno potrà mai arrivare a celebrare criminali, camorristi e mafiosi tanto più se ama la propria storia e la propria terra e lo stessa rassicurazione posso darla in merito alle sue preoccupazioni su un eventuale progetto per “riportare sul trono un Borbone” (in tal caso, per chi avesse questo tipo di progetto nel suo cassetto, ci sembra di sentire più le sirene di un’ambulanza che di una pattuglia di poliziotti auspicata dall’autore). Non si vedono ancora “Carli di Borbone” in arrivo a Porta Capuana…
Entrando nel merito, ci sorprende anche un altro aspetto: per oltre due secoli centinaia di cronisti italiani e stranieri del tempo e centinaia di storici per giunta più “giacobini” che “borbonici” (Croce in testa) non avevano mai riportato notizie relative alla diffusione del cannibalismo.
L’autore, allora, sembra preparare i lettori ad un grandioso ed epocale scoop ma (anche se con il rischio di “spoilerare” il libro) dobbiamo avvertirvi che non siamo di fronte ad uno scoop grandioso ed epocale. Una decina le fonti e gli episodi citati e per giunta ripetuti più volte. In una sorta di “excusatio non petita”, è lo stesso autore ad anticipare eventuali critiche: “oltre dieci testimonianze attestano fatti cannibalici” e chi ne contesta la validità dovrebbe ipotizzare una “sorta di mostruosa montatura architettata da chi e perché”. In realtà la questione non è quella che l’autore pone: le fonti che riporta e presenta come “pubbliche, private, ufficiali, borboniche e repubblicane” non ci sembrano affatto numerose e neanche adeguate per giustificare una tesi così complessa e un libro intero.
Si tratta di fonti che attestano notizie diverse, spesso poco chiare, spesso corrette in un secondo momento. Si citano più volte (31!) i Giornali di Diomede Marinelli, cronista non proprio “imparziale” (era fratello di Angelo, giacobino prima condannato a morte e poi inviato in esilio dai Borbone) e che in un paio di occasioni usa anche la parola “forse”. Si tratta del Diario di Carlo De Nicola che, come scrive lo stesso autore, scriveva “de relato”, con notizie attinte da altri e che riportano più volte lo stesso episodio in un caso parlando di “due cadaveri” e correggendosi dopo con “un solo cadavere”. Si tratta di qualche poeta che parla genericamente di “ottimi pasti”.
Del resto lo stesso autore esprime qualche dubbio sulle sue stesse fonti: “possibile che le fonti esprimessero più di quanto accaduto per motivazioni diverse ma legate eminentemente a dinamiche della lotta politica”. A questo proposito cerca delle controprove che, secondo il nostro parere, non riesce a fornire. Tutto gira intorno all’uccisione di Nicola Fiani (citato per 20 volte nel testo) e del successivo scempio che si fece dei suo resti ed è da evidenziare, tra l’altro, che si tratta dell’unico caso citato in maniera specifica (insieme ad un altro paio di casi extra-napoletani). E così si parla di “autocensure” e “ritrosia” per due delle fonti citate. Tra esse il famoso saggio di Vincenzo Cuoco che nell’edizione del 1801 fa riferimento agli “infelici resti che il popolo mangiava”: nell’edizione del 1806 quel passaggio sparisce o, come dice l’autore, “gli resta nella penna”. Perché mai -ci chiediamo noi- Cuoco avrebbe dovuto auto-censurarsi quel passaggio dopo 5 anni? In 5 anni era diventato “neo-sanfedista” o semplicemente (come fanno spesso gli storici) aveva acquisito altre notizie che smentivano le prime? Stesso strano schema applicato con un’altra fonte: la relazione di Francesco Lomonaco che, pur utilizzando toni accesi, non parla mai di cannibalismo con un generico e quasi poetico passaggio (“carnivori satelliti di Maria Carolina”). Paradossale che l’autore citi queste fonti che negano la sua tesi giustificandole come frutto di ipotetiche e indimostrate auto-censure.
Stessa ambiguità e forse stesso schema per un’altra fonte relativa allo stesso episodio: la Confraternita dei Bianchi preposta all’assistenza dei condannati e che in un primo documento attesta episodi di cannibalismo. Anche in questo caso si può supporre che si tratti di episodi il cui racconto girava in città (la relazione riferisce di lazzari che giravano con resti “quasi in vendita”) ma in un secondo documento, quello più importante e nel quale si richiedeva l’intervento delle autorità, la relazione diventa generica e non ci sono più riferimenti a quegli episodi per giunta proprio nel momento in cui i Bianchi avrebbero potuto e dovuto rendere il quadro più drammatico per ottenere quell’intervento (che arrivò subito dopo ordinando la sepoltura subito dopo le esecuzioni). Poco chiara anche un’altra fonte ufficiale: un documento del Direttore di Polizia che riferisce i fatti relativi sempre a Fiani, denuncia “ferocia e sevizie” ma non parla mai di cannibalismo. E non ne parla neanche un’altra fonte pure riportata (non sappiamo perché, visto che si tratta di fonti che di fatto negano ancora la tesi centrale): una cronaca anonima che tra l’altro riferisce anche una “motivazione” di quella rabbia assurda del popolo contro il Fiani (che, prima dell’esecuzione, avrebbe mostrato le terga al popolo insultando anche il re).
Poco chiara anche la fonte “borbonica” riportata: il cardinale Ruffo chiese il sequestro di “dipinture indecentissime rappresentanti […] parti di corpo dilaniate esposte in mano di uomini e rappresentate su dei piatti” (si tratta di dipinti di atti crudeli ma non di una testimonianza che conferma quegli atti, frutto magari di quelle esagerazioni di cui lo stesso autore aveva parlato). Ancora lo stesso schema per un’altra fonte ancora una volta indiretta: il marchese Malaspina (“vi è chi perfino ha veduto arrostire la carne umana”).
A questo punto sentiamo di scusarci con i nostri affettuosi lettori per la citazione di passi comunque orrendi e che dimostrano (eterogenesi dei fini?) che l’autore stesso forse è caduto nella trappola che temeva riferendola ad altri studi (il rischio di “una grandguignolesca etnografia degli eventi in nome di un malinteso gusto per il macabro”).
Detto questo, il resto del libro è dedicato al fenomeno del cannibalismo in Italia (compreso il cinquecentesco e sabaudo Piemonte) e in Europa tra il Quattrocento e l’Ottocento e, visto, lo spazio dedicato a questo tema, ancora non si capisce perché mai il titolo richiami solo i “nostri” lazzari e per giunta anche i Borbone che non c’entravano nulla con questo ipotetico fenomeno e, come attesta lo stesso autore, arrivarono a temere reazioni popolari che lo stesso autore inquadra più volte come “anarchia” (a occhio, l’esatto contrario di “monarchia”). Si tratta comunque di casi tutto sommato isolati e che non tengono conto neanche di un altro aspetto magari riferibile alle patologie mentali dei (pochi) protagonisti senza la necessità di condannare popoli interi e storie intere.
Su tutto, però, emerge una gigantesca lacuna: il libro non contestualizza le reazioni violente del popolo napoletano che, con disprezzo, viene definito troppe volte “lazzaro”. La domanda è ovvia: com’è possibile che, in due millenni di storia, un popolo tra l’altro profondamente legato ai valori cristiani sia diventato così “feroce” o addirittura “cannibale” solo nel 1799? Cosa successe in quei terribili mesi? Incredibile a dirsi ma l’autore non lo spiega. Eppure si tratterebbe di uno schema semplice: azione e re-azione, invasione e (legittima) difesa… perché da sempre nella storia dell’umanità chi viene attaccato ha il diritto di difendersi e più si è attaccati con ferocia più ci si difende, purtroppo, con ferocia. E così l’autore non dice una sola parola sui massacri compiuti dai francesi e dai giacobini tra il 20 e il 22 gennaio del 1799 all’ingresso nella capitale e con gli oltre ottomila morti di parte napoletana-cristiana-borbonica. Non dice una sola parola sulle centinaia di condanne a morte eseguite senza processi e nelle piazze (anche solo per “aver gridato viva il re”). Non dice una sola parola su quello che raccontarono gli stessi generali francesi (in testa il generale Thiebault nelle sue Memorie): nei 5 mesi di repubblica napoletana “furono passati a fil di spada non meno di 60.000 napoletani [meridionali]”. Non dice una sola parola sui successivi eccidi (donne e bambini inclusi e sgozzati e penso soprattutto alle Calabrie e a Lauria con la sua “onda dei morti”) in tutto il Sud con la nuova invasione francese tra il 1806 e il 1815 (decine di migliaia di vittime).
In genere la storiografia ufficiale, di fronte alle denunce delle vittime del brigantaggio post-unitario, giustifica tutto con le brutali “ragioni di una guerra”. E non fu forse una vera guerra con tutte le sue drammatiche e terribili conseguenze quella che il popolo napoletano combatté per giunta contro un’invasione inequivocabilmente straniera?
“Basta tacere su quel che è accaduto ‘prima’ perché la reazione degli offesi sembri una barbarie” (Murid al-Barghuti). Più che mai appropriata, per questo libro, la poesia del poeta palestinese citato anche da Pino Aprile in “Carnefici”.
In questo libro, infatti, non c’è alcun riferimento alle cronache di Forest o di Broussier e di tanti cronisti del tempo con intere città ridotte in cenere, stupri, saccheggi, fucilazioni sul posto, “morti legati ai vivi”, massacri indiscriminati di donne, vecchi e bambini, profanazioni di chiese e conventi. E niente è scritto sulla miseria e la disperazione che si diffondevano per le strade, con il “commercio proibito”, “i mulini chiusi”, “le acque che non venivano”, le “contribuzioni militari esosissime” o le migliaia di capestri pronti per i napoletani anti-giacobini (De Nicola e “Relazione a guisa di lettera”, tra gli altri).
“Scannateli, bruciateli, inceneriteli, lavatevi nel loro sangue, mangiatevene il cuore e le viscere”: sono le parole del cittadino Bruno Gagliano nel suo appello contro i nemici della patria (giacobina) e in questo libro non le trovate (Miscellanea, Società Napoletana di Storia Patria).
E così sembra quasi che un popolo dalla storia antica, gloriosa e famosa sia impazzito all’improvviso abbandonandosi ad efferatezze e a crudeltà gratuite. La violenza è sempre e comunque da condannare ma, visto che parliamo del Settecento e visto che qualcosa era successo da queste parti in quegli anni, sarebbe stato corretto raccontarlo evitando una sorta di generale “criminalizzazione” e cercando in tutti i modi precedenti e scenari che potessero giustificare la ricostruzione di una storia “violenta ed efferata” (e penso alla citazione addirittura degli orchi antropofagi del grande e seicentesco Giambattista Basile, utilizzato come se quei mostri fossero solo napoletani e non appartenessero all’immaginario mostruoso in tutti gli angoli del mondo e in ogni tempo).
E così l’autore non avrà dato affatto importanza alle famose dichiarazioni del deputato milanese Giuseppe Ferrari quando cercava di far capire le ragioni dei “brigantaggi” meridionali: “voi potete chiamarli briganti, ma i padri e gli avoli di questi hanno per ben due volte ristabiliti i Borboni sul trono di Napoli, ed ogni qual volta la dinastia legittima è stata con la violenza cacciata, il napoletano ha dato tanti briganti da stancare l’usurpatore e farlo convincere che, nel Regno delle Due Sicilie, l’unico sovrano che possa governare, dev’essere della dinastia borbonica, perché in questa famiglia reale soltanto si ha fede, e non in altri”. E Ferrari pensava al 1799 oltre che al 1860. Altro che “epopea brigantesca alimentata dai Borbone dopo l’unità e sconfitta da una repressione brutale ma non meno di quella attuata dai Borbone nel 1799”. Tesi, quest’ultima, che contraddice quanto scritto in precedenza (l’anarchia del popolo) e che contrasta, forse, con la logica (un conto uno Stato come quello sabaudo, protagonista di una repressione così feroce, un altro una reazione popolare).
Se lo stesso generale francese Thiebault, del resto, descrisse quello che il popolo subì (“Napoli era un immenso campo di sterminio, tutto era bruciato, fulminammo tutto ciò che era vivo”) e se in ogni casa doveva esserci un morto, un ferito o una vittima, si poteva mai pensare che il popolo non avrebbe reagito e non si sarebbe (purtroppo) vendicato? Perché solo da queste parti si pubblicano libri di questo tipo e perché quei “difensori eroici della Patria napoletana” opposti ai “traditori repubblicani” (sono le parole che usò Mazzini in un manoscritto sul 1799 che l’autore non conosce o non riporta) qui sono “lazzari” da disprezzare? Perché non evidenziare quello che lo stesso Cuoco fu costretto ad ammettere con l’ammirazione per il “coraggio” di un popolo capace di resistere ad un intero esercito, in popolo “vinto ma non avvilito”. Perché in Spagna Goya ha dedicato quadri e disegni agli eroici difensori della Spagna contro i francesi e qui si vanno a cercare, ad ogni costo, anche le notizie più nascoste per dimostrare che era una “feroce plebaglia”?
Ecco. Al di là degli aspetti spesso contraddittori, poco chiari e poco convincenti di questo libro che abbiamo letto davvero con fatica, quello che colpisce e che resta è proprio questo: l’idea che non ci sia ancora una storiografia “ufficiale” obiettiva e rispettosa di tutta la nostra storia, elemento forse fondamentale per un riscatto non solo culturale e uno dei sicuri motivi del successo di quella “macchina comunicativa neoborbonica” di cui parla l’autore nelle prime pagine.
Gennaro De Crescenzo
SINTESI E RIEPILOGO DELL’ ANALISI Poche le fonti e pochi gli episodi citati (in tutto una decina, di cui solo uno in maniera specifica); alcune fonti, per giunta, prima riportano episodi di cannibalismo e, in un secondo momento, li cancellano; molte fonti anche di parte estremista-giacobina non riportano affatto questi episodi (molto debole la tesi che giustifica queste assenze e secondo la quale prevalse una “auto-censura”, più probabile la tesi secondo la quale si trattava di casi magari isolati e riferibili a patologie personali e/o al centro di racconti più o meno fantasiosi diffusi in quei giorni di drammatica tensione e smentiti dopo ulteriori verifiche). Il testo cita diversi (ma non numerosi) episodi diffusi in Europa tra Quattrocento e Ottocento ed è del tutto pretestuoso un titolo che associa il fenomeno ai Borbone e a Napoli. Il testo non riporta le (vere) motivazioni della rabbia popolare scatenata (come in qualsiasi guerra di ogni luogo e ogni tempo) come re-azione ad un’azione (un’invasione straniera, saccheggi, violenze e un massacro di oltre 60.000 persone). Nella bimillenaria storia di Napoli e del Sud, del resto, non si era mai registrata la diffusione di questo fenomeno e nessuno potrà mai spiegarci come sia stato possibile registrarlo solo nel 1799.